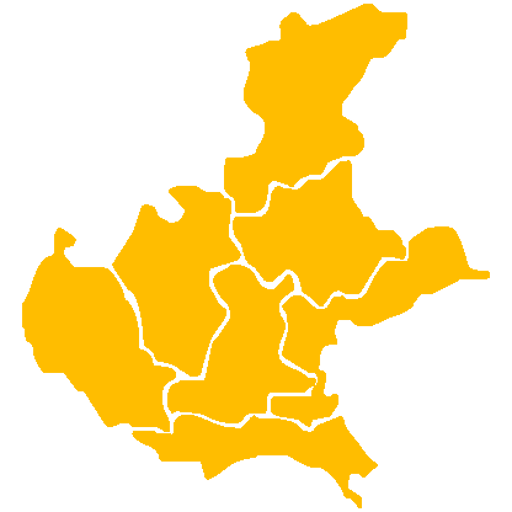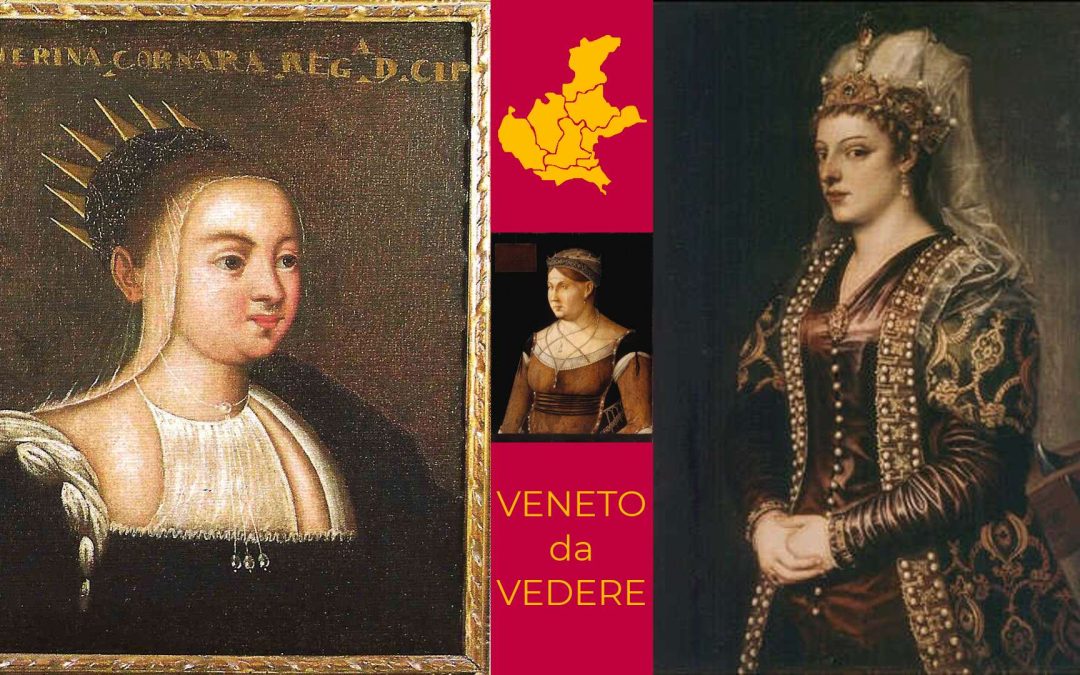Articolo scritto da Alvise Zorzi nel gennaio del 1990, nel primo numero della rivista.
Noto studioso della storia di Venezia, fu l’autore dell’articolo che segue.
L’arrivo di Caterina Cornaro
Era il mattino del 6 giugno 1489: cinque secoli fa, giusti giusti [1990 ndr].
E Venezia era in festa; ma non per una delle continue celebrazioni di solennità religiose e di stato che ne facevano, per dirla con Edward Muir, una città di processioni.
L’avvenimento che aveva portato il Doge Agostino Barbarigo, a bordo del Bucintoro assieme alla Serenissima Signoria e ad uno stuolo di senatori, con la scorta dei ‘ducali peatoni‘ lussuosamente addobbati, a muovere dal bacino di San Marco a San Nicolò di Lido, era assai più importante del consueto.
La famiglia Corner (o Cornaro)
Dopo una lunga traversata, era sbarcata al Lido la regina di Cipro, ed il fatto che la regina fosse una patrizia veneziana di casa Corner, e che avesse fatto dono del suo regno alla Repubblica di Venezia, era più che sufficiente a giustificare un rituale assai più grandioso dell’ordinario.
La donna che il Doge era venuto a ricevere aveva avuto un singolare destino.
Caterina Corner (o Cornaro, secondo la lezione umanistica del suo cognome, preferita, in genere, dai biografi) apparteneva ad una grande casata del patriziato. Che faceva risalire la propria origine alla romana gens Cornelia e aveva avuto un doge (altri tre ne avrebbe avuti prima della fine della Serenissima).
Ma soprattutto, aveva accumulato ingentissime ricchezze in avvedute imprese economiche in Levante. Così da essere stata in condizione di largire grossi prestiti alla dinastia regnante a Cipro: i Lusignano. Afflitti da una cronica mancanza di danaro.
Possesso di Cipro
Dai prestiti era conseguito, per una linea di casa Corner, il possesso di un grosso feudo a Cipro. Dove essa aveva avviato una fiorente attività nella coltivazione della canna da zucchero.
Ma anche il ramo di Caterina, che discendeva direttamente dal Doge Marco, aveva saputo far fiorire la proprie iniziative economiche nella grande isola del mar di Levante, già sfruttata e spremuta dai genovesi.
Così, quando re Giacomo II aveva deciso di sposarsi, gli era sembrato avveduto cercarsi una sposa in casa Corner. Era nato illegittimo, si era impadronito del trono con l’astuzia e la violenza. L’appoggio della potente Repubblica gli sarebbe stato prezioso, quanto sarebbe stato utile ai Corner aumentare la loro influenza nel regno. Ed alla Repubblica, mettere saldamente piede a Cipro.
Tanto più, per quanto riguardava Venezia, che i Turchi, impossessatisi alla metà del secolo [XV° ndr] di Costantinopoli, si erano impadroniti anche della più ricca fra le molte colonie veneziane, Negroponte, l’Eubea.
Caterina Cornaro – Regina

Così Caterina Cornaro era diventata regina.
Ma re Giacomo II era morto prematuramente. Il bimbo che Giacomo le aveva dato era morto in fasce, e la Serenissima aveva imposto un protettorato sempre più stretto sul regno.
Verso il quale guardavano con occhio cupido altre potenza mediterranee. Primo fra tutti Ferdinando d’Aragona, re di Napoli.
C’erano stati episodi sinistri, congiure e colpi di mano gestiti a distanza dall’Aragonese. Fino a quando la Repubblica aveva spedito alla regina il fratello di lei, Giorgio. Per convincerla a far dono del suo regno alla patria d’origine.
Sia pur riluttante, Caterina si era piegata. La Repubblica, riconoscente, oltre a riserbarle un’accoglienza trionfale, le aveva decretato un sostanzioso appannaggio: la conservazione delle prerogative regali, e la signoria di una città del proprio territorio.
Asolo

Il fatto che la città prescelta sia stata Asolo, una delle più belle e raffinate del Veneto, ha senza dubbio contribuito a far crescere il mito di Caterina Cornaro. La cui vita è stata raccontata, con dovizia di particolari spesso del tutto immaginari, da molti scrittori italiani e stranieri, e la cui vicenda ha fornito lo spunto persino ad un’opera di Donizetti.
E, in verità, la vicenda della bella veneziana andata in sposa al re di un remoto reame d’origine crociata, rimasta prematuramente vedova e spodestata, sembra fatta apposta per sollecitare la fantasia dei poeti, se non dei musicisti.
Tanto più che alla corte asolana era approdato un illustre, lontano parente della bella regina: Pietro Bembo. Futuro cardinale. E, probabilmente, vi si era affacciato anche Giorgione, che era nativo di Castelfranco Veneto, a due passi da Asolo. Il quale deve aver affrescato la dimora campestre di Caterina Cornaro: il cosiddetto Barco.
Nel nostro dialetto veneto barco sta per fienile. Con umanistica civetteria così il Bembo aveva battezzato un podere di un centinaio di ettari. Tutto giardini e boschetti, in mezzo al quale era sorta una fastosa residenza, ohimè quasi del tutto scomparsa.
Considerazioni sull’episodio

In questo quinto centenario, che vede svariate iniziative intese a commemorare sia la cessione di Cipro a Venezia, sia e soprattutto la presa di possesso di Asolo da parte di Caterina Cornaro, è possibile tirare le somme della vicenda di lei senza indulgenze romantiche.
Riconoscere in lei non tanto la vittima della ragion di Stato e degli appetiti della Serenissima che i biografi hanno dipinto. Quanto la pedina di un giuoco di potere giuocato, più ancora che dalla Repubblica che aveva ben altre corde al proprio arco, da casa Corner.
Pedina, forse, non tanto infelice quanto la tradizione romantica l’ha voluta dipingere. Così forte era lo spirito di casta nelle patrizie del suo tempo. Per non parlare del patriottismo, caratteristica esasperata del suo mondo, da farle trovare un compenso alla perdita del regno nella straordinaria elevazione sociale ed economica della sua famiglia.
Erano i Corner che, infatti, ritraevano il massimo utile da questa lunga e complessa operazione politico-dinastica.
Prima di tutto, perchè avere una regina in famiglia era, per quei tempi, il massimo dell’achievement sociale immaginabile.
Poi, perchè al mediatore della cessione del regno, Giorgio Corner, venivano conferiti i massimi onori repubblicani.
Poi ancora, perchè il potenziale economico di quel ramo dei Corner ne ritraeva un accrescimento tale, che i figli di Giorgio, nipoti di Caterina, saranno oggetto di universale meraviglia per le immense ricchezze accumulate, e daranno vita a tre palazzi grandiosi al punto di rappresentare da soli una testimonianza del successo della famiglia.
I tre palazzi Corner
Palazzo di San Polo, sede del ramo primogenito, quello che darà alla Repubblica tre dogi, e alla chiesa sette cardinali.
Opera di Michele Sanmicheli.
Quello di San Cassiano, rifatto in forma solenni ai primi del Settecento.
Il terzo, più grande e splendido di tutti, quel palazzo Corner a San Maurizio, sul Canal Grande, opera del Sansovino. Che è oggi [1990 ndr] sede della prefettura di Venezia, ed è da sempre conosciuto come Palazzo Corner ‘de la Cà Granda‘.
E lei?
Della sua vita privata nulla possiamo sapere. Ben poco di lei rimane. Qualche lettera famigliare, un testamento che conferma il suo legame affettivo col fratello Giorgio, lasciato erede universale.
Ma la vediamo, fino alla morte, sopravvenuta nel 1510, brillare nella società come first lady incontestata. Ad Asolo come nel palazzo di San Cassiano, e nella sontuosa villa di Murano, dove riceve le gran dame italiane del suo tempo: Isabella Gonzaga marchesa di Mantova, Beatrice Sforza duchessa di Milano.
Quando si muove per andare a far visita a Giorgio, podestà veneziano a Brescia, è un’apoteosi. Sono festeggiamenti senza fine. Giostre, banchetti, tornei.
Non c’è alcuna testimonianza che avvalori l’immagine di una donna tristemente ripiegata su se stessa in un misticismo che non risulta da nessuna parte.
Nè quella di un’esiliata che rimpiange il perduto reame. Del quale sembra si sia ricordata ben poco, se non per la presenza alla sua corte di dame damigelle e cavalieri ciprioti, oltre che del celebre nano Zavir.
Di lei ci rimane un solo ritratto certo, in uno dei telèri dei miracoli della Croce, di Gentile Bellini. Anziana ormai, ingioiellata, autorevole, alla testa di uno stuolo di dame.
Che non nutrisse rimpianti, ma pensasse piuttosto ad un ulteriore accrescimento della potenza familiare, e di quella veneziana, lo dimostra un episodio che, per lo più, i biografi romantici passano sotto silenzio: la richiesta di cinquantamila ducati, ancora dovuti dalla repubblica, per farne dote di una nipote, figlia di Giorgio, da maritare a re Ferrante d’Aragona, detto Ferrantino, figlio di Alfondo II di Napoli. Il quale, a garanzia della dote, avrebbe ceduto a Venezia la città di Manfredonia purchè la Serenissima lo prendesso sotto la sua protezione…
Papa Alessando VI, che temeva che Napoli facesse la fine di Cipro, mandò a monte la combinazione. E in casa Corner non entrò un’altra corona.
Asolo
1990
Il nome di Caterina Cornaro vive ancora ad Asolo. Ricordo di un momento di inaudito splendore per quella dolcissima cittadina. Tanto cara a Robert Browning, a Gian Francesco Malipiero. E, grazie all’intervento della Fondazione Benetton, ciò che rimane del barco rifiorirà in un giardino, dal quale, nel nome di Carlo Scarpa, architetto veneziano, partiranno iniziative destinate a premiare i più bei giardini e a conservare e a far rivivere gli antichi giardini del Veneto e d’Europa.
2022
Comprendiamo che per un intellettuale, le ‘celebrazioni’ di un cinquecentenario possano -forse- avere un reale valore commemorativo. Ma in tutta franchezza crediamo che, senza ipocrisie, a distanza di 500 anni, l’unica motivazione dietro ogni iniziativa, sia quella venale.
Turistica, innanzi tutto. Richiamare ad Asolo qualche turista che spenda del denaro nelle botteghe e nei ristoranti locali. E pseudo culturale: soldi pubblici spesi a beneficio di qualche dimenticato ufficio altrettanto ‘pubblico’, stipendiando qualche persona, che rovista in qualche archivio.
Nulla di condannabile in questo, sia chiaro. Ma far passare certi eventi come ‘iniziative intese a commemorare’ questo o quello, ci sembra un tantino ‘romantico’. Certamente non corrispondente alla realtà. In generale, per tutte le iniziative di questo tipo. Non solo per Caterina Cornaro ad Asolo.